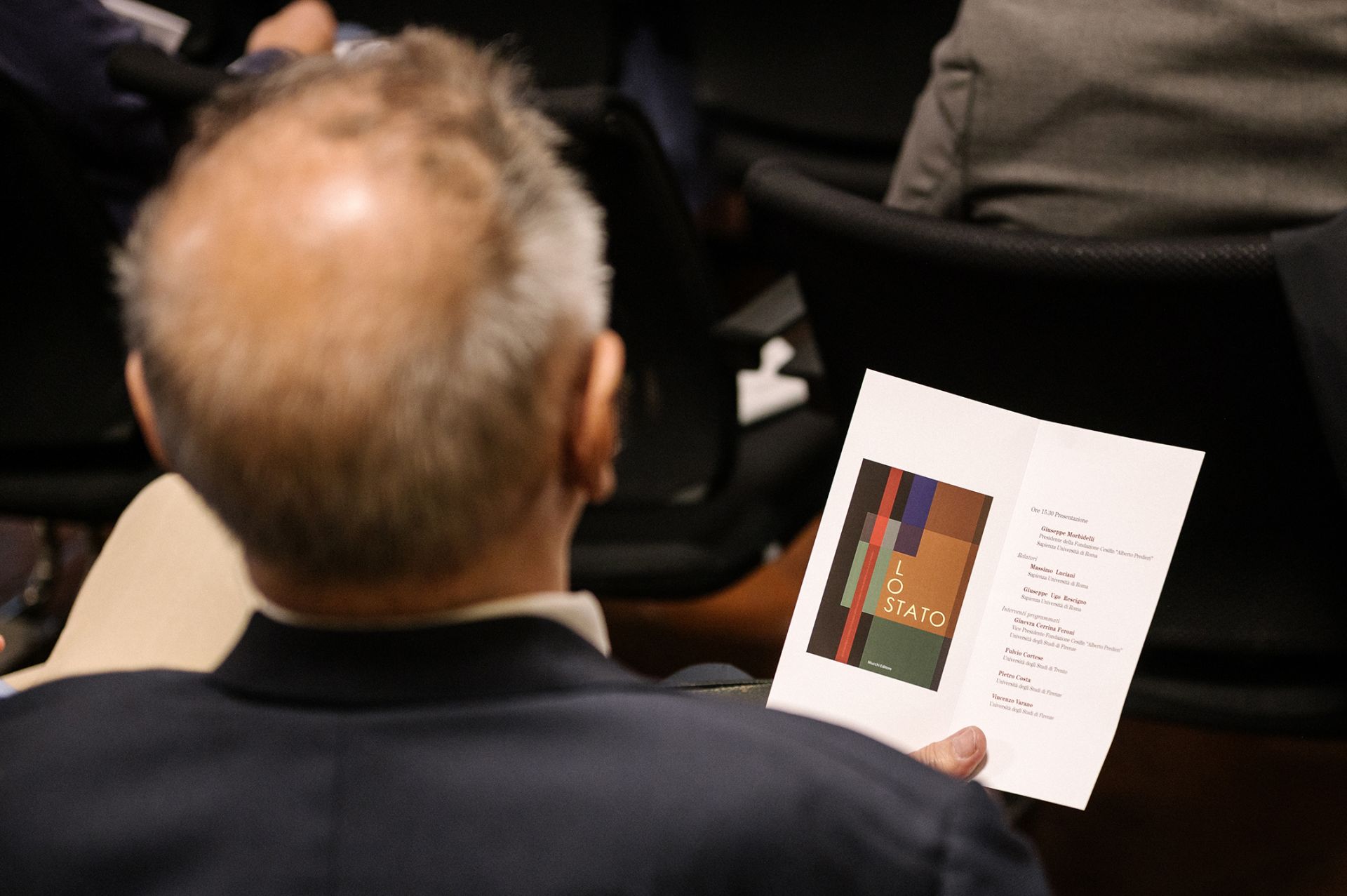La politica culturale attraverso una rivista scientifica
Grazie per avermi chiamato a partecipare a questa celebrazione, che in realtà è una discussione su un impegnativo progetto editoriale.
«Je me fais de l’université une idée plus médiévale». Con queste parole Michel Villey prendeva posizione sulle riforme universitarie francesi degli anni Settanta e Ottanta e la prendeva quando aveva ancora un senso farlo. Oggi ne ha meno, perché non solo non esiste più quell’università medievale, ma non esiste più (salvo qualche distinguo di cui dirò) nemmeno la sua forma - diciamo così - humboldtiana, la quale a ben vedere costituiva la proiezione e l’adattamento illuministico di quell’antico modello. Che le cose stiano così, nondimeno, non vuol dire ch’esse tali debbano restare. Non v’è - infatti - alcun vincolo promanante da chissà quali superiori fonti che obblighi a conservar le cose in questo stato. Non c’era in occasione della triste vicenda del 3+2, quando ci fu fatto credere all’esistenza di un vincolo europeo (mentre c’erano i soli “princìpi di Bologna”, stipulati in una riunione che non era nemmeno ai più alti livelli politici) e non c’è adesso.
Questo vuol dire che se non si vuole che si perpetui la desolante condizione attuale occorre sforzarsi di contrastarla e occorre farlo anche promovendo politica culturale, nella consapevolezza che i problemi sono risolvibili unicamente nel tempo medio, se non addirittura lungo. Ebbene: Lo Stato è un episodio importante di questa possibile politica culturale e lo è oggettivamente, non perché oggi celebriamo questa rivista di fronte a chi l’ha fondata ed è nostro amico.
A pagina 30 dell’Editoriale che apre l’ultimo numero, che ovviamente si deve ad Aljs Vignudelli, si danno delle indicazioni di metodo che trovo convincenti: «Lungi dall’esprimere rassegnazione, anche alla luce della situazione descritta, la stessa decisione di fondare questa rivista è da intendere come sintomo di uno sguardo fiducioso verso il futuro, e pronto a cogliere il buono pure nel presente». Ora, per cogliere il buono pure nel presente ce ne vuole; ci vuole molta buona volontà e molta fantasia, tuttavia è meglio sforzarsi di provarci anziché limitarsi a fare infruttuoso esercizio di nostalgia, così mobilitando le straordinarie risorse che anche in questo fosco presente continuano a essere disponibili. Pensiamo, a tacer d’altro, a quanto ci offre la rete, all’incredibile messe di fonti e di dati online che da giovani potevamo solo sognare di possedere e che ora sono opportunità straordinarie tali da autorizzare a gettare uno sguardo - pur cautamente - fiducioso nel futuro.
Occorrono però iniziative capaci di aprire un varco, di creare contraddizioni nell’attuale condizione. Occorrono appunto iniziative come questa, che Aljs Vignudelli ha condotto e conduce con l’insostituibile aiuto dei suoi validissimi allievi e collaboratori.
Ma torniamo all’Editoriale che ho appena ricordato e assumiamolo a punto di riferimento, perché si tratta di un contributo che – potremmo dire prendendo all’imprestito una nota concettuologia costituzionalistica – è allo stesso tempo di bilancio e di programma. Esso fa il punto su dieci anni di storia de Lo Stato e, se ha certo ragione Beppe Morbidelli a dirci che dieci anni non sono poi chissà quanti nella vita di una rivista, resta anche vero che, con i ritmi accelerati del tempo di oggi, si tratta pur sempre di un significativo lasso di tempo.
L’Editoriale ha una singolare struttura. Nelle prime pagine ci si immerge nelle caliginose atmosfere della Bassa padana: sentiamo profumi di gnocco fritto e di culatello di Zibello; ci troviamo bambini con i calzoni corti sui banchi di legno, su quei banchi pieni di graffiti a punta di temperino - nemici della comodità e forse amici degli ortopedici - che alcuni di noi hanno sperimentato. Si tratta di una parte che - Aljs lo sa - mi è piaciuta moltissimo: sembra di leggere un racconto di Guareschi; ci si trova improvvisamente in una dimensione quasi onirica. Eppure, quelle pagine non vanno lette solo pel loro pregio letterario o come un amarcord nostalgico. Certo, là dentro c’è un pezzo di vita di Aljs che balza agli occhi con grande vivacità e vivezza, ma c’è anche e soprattutto l’idea che quelle cose andavano scritte per poggiare sulla tavola una sorta di segnaposto della rivista, una qualche marcatura della sua collocazione nella storia, nel fluire della storia e della cultura del Paese.
L’Editoriale propone una complessa filatura di trame di collegamento tra la cultura e l’università che furono e la cultura e l’università che sono oggi, ma fa bene intendere come quella cultura e quell’università scomparse non appartengano a un passato remoto, ma siano - semplicemente - il nostro ieri. Si scrive a pagina XVI: «la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna alla quale ero approdato nel 1967 era [...] un esempio di classicità e compostezza, con un corpo docenti a dir poco stellare». Potrei dire lo stesso della Facoltà giuridica de La Sapienza romana. E potrei dirlo anche non più da studente, ricordando l’anno in cui ritornai da giovane chiamato nel 1996: non chissà quando, ripeto, ma ieri, appunto. Eppure, tanto è cambiato.
C’è a pagina XVII una frase molto bella: «poi è arrivato, furiosamente, il Novecento». È arrivato, in realtà, il Sessantotto e qui si dovrebbe aprire una discussione su ciò che il Sessantotto è stato, anche se lo si dovrebbe fare rifuggendo dallo stucchevole ideologismo che tuttora inquina il confronto. Oggi posso solo limitarmi a mettere in luce il punto – che a me sembra essenziale - della rottura del principio di autorità ch’esso portò con sé, una rottura che positivamente travolgeva l’autoritarismo gerarchico, ma negativamente metteva in discussione anche la stessa autorevolezza, compresa l’autorevolezza riconosciuta alle conoscenze. In ogni caso, il Sessantotto non spiega tutto, non spiega affatto, interamente, la nostra condizione attuale, perché molte altre cose andrebbero tenute presenti.
Mi ha divertito il fatto che a pagina XXII si citi Idiocracy, un filmino - forse un B movie - che anch’io ebbi a ricordare ai miei studenti e che può vedersi su una delle molte piattaforme disponibili in rete. Vi si racconta la storia di un uomo qualunque, di intelligenza media o forse medio-bassa, il quale, per una serie di circostanze fortuite, si ritrova crioconservato per moltissimi anni e al risveglio scopre di essere considerato un genio assoluto: è accaduto, infatti, che il mondo, nel frattempo, s’è popolato di perfetti imbecilli. Il film, divertente pur nella sua semplicità, mette in luce i gravi rischi dei tempi nostri, che potrebbero avere gravi ripercussioni sul futuro. È infatti enormemente aumentato il rischio del cultural divide, perché le nuove tecnologie non offrono solo le grandi opportunità di apprendimento cui accennavo, ma anche numerose occasioni di rimbambimento: occasioni di approfondimento, di acculturazione diversa e ramificata, assai più complessa di quella che noi potemmo esperire negli anni della nostra formazione; ma anche occasioni di abbrutimento, di fruizione passiva di tutto quanto passa nei meandri della rete. Si tratta di una partita aperta, anche se si deve essere consapevoli del fatto che le prospettive peggiori hanno a disposizione delle autostrade, mentre le migliori hanno di fronte soltanto dei sentieri, magari dei sentieri interrotti, degli Holzwege.
È sull’incerto crinale tra l’abisso e la resurrezione che – a me sembra – si muove questa iniziativa editoriale. E vi si muove sulla base di una premessa, accennata a pagina XXIII e poi meglio esplicitata alle pagine XXVII e XXVIII, che in realtà è una presa di posizione, una dichiarazione di appartenenza, una rivendicazione di scuola: «l’idea elementare che si nutriva allora è che il diritto di cui solo valeva la pena di occuparsi fosse quello positivo e che quest’ultimo, perlomeno nei nostri ordinamenti continentali di civil law, fosse ovviamente quello posto ed esternato per iscritto dal legislatore costituzionale e ordinario e che il compito primo della scienza giuridica fosse, in qualità di metalinguaggio, di ricostruire avalutativamente caratteristiche e contenuti del linguaggio oggetto». Tutto questo, si aggiunge, ha lasciato il posto ad altri indirizzi scientifici, ad altre metodologie, e non ci sorprende che ciò si aggiunga con toni critici, perché quale fosse la posizione scientifica di Aljs Vignudelli era noto. Non ci sorprende, appunto, leggere alcuni passi in cui si mette in luce cosa non va. E cosa non va è soprattutto questo: «la vasta gamma di soluzioni caso per caso, le ormai frequenti operazioni di supplenza degli organi giusdicenti, una classe politica distratta, sorda o anche soltanto ipocrita nel non decidere».
Abbiamo, da una parte, un difetto di consapevolezza dei limiti della giurisdizione e dall’altra un difetto di volontà di adempiere ai compiti che sono propri della legislazione. Su tutto questo grava, poi, l’imbarbarimento del dibattito pubblico (si pensi, paradigmaticamente, alla recentissima discussione su un provvedimento giurisdizionale in materia di immigrazione, oggetto di critiche a dir poco sopra le righe). Rincara la dose Aljs parlando di una «infinita serie di sofismi e paralogismi di cui abbonda l’odierna letteratura giuridica, critiche a formule come dialogo tra le Corti, disordine delle fonti» e a pagina XVIII rivela che «è stato proprio anche per reagire al senso di disorientamento determinato da un simile scenario, che nel 2013 abbiamo deciso di dar vita al progetto di cui celebriamo qui il decennale». Un progetto che, si badi, non ha una sua specifica connotazione ideologica, ma vuol fare politica culturale a prescindere da qualunque obiettivo ideologicamente caratterizzato. Che sia così l’attestano dieci anni di rivista; lo dichiarano le affermazioni esplicite di pagina XIX («Lo Stato può forse rientrare nella categoria di quelle che [...] Giannini definiva riviste di dibattito, nel senso che non intende affermare una determinata linea redazionale, ma fa proprio un atteggiamento di apertura nei confronti dei diversi orientamenti»); lo dimostrano gli stessi importanti contributi, ospitati proprio sull’ultimo numero della rivista, che seguono una metodologia giuridica e scientifica lontana le mille miglia da quella prediletta da Aljs e anche dalla sua scuola.
Alla luce di queste considerazioni chiuderei su un interrogativo: cosa deve fare il giurista, il giurista che ha da misurarsi con problemi di questa portata? Cosa deve fare il giurista che intende contrapporsi allo smarrimento della scienza giuridica? È ovviamente ben difficile da dire, ma a mio avviso deve anzitutto avere un contatto con le altre scienze dello spirito e in generale con tutte le altre scienze. La scienza giuridica ha qualche difficoltà a farsi ospitare nel classico dualismo windelbandiano che distingueva tra scienze nomotetiche e scienze idiografiche, poiché esibisce tratti propri dell’una e dell’altra famiglia, ma proprio per questo è una disciplina (chiamiamola così, se “scienza” ci sembra troppo impegnativo), che è caratterizzata da una naturale apertura verso gli altri tipi di conoscenza. Chi rimprovera al giurista d’essere chiuso nel suo particulare forse non si rende conto ch’egli – invece – proprio a causa di questa indeterminatezza del suo ubi consistam è addirittura costretto a guardare al di là degli apparenti steccati specialistici dei suoi studi. Apertura, poi, è anche interdisciplinarità, frequentazione di biblioteche che non siano esclusivamente giuridiche, presenza nella propria biblioteca di libri che non siano soltanto di diritto; dialogo fitto con gli altri specialismi.
L’ultimo numero de Lo Stato, da questo punto di vista, è un paradigma e basta scorrere l’indice per intenderlo: la fittissima interlocuzione con le altre scienze dello spirito è attestata, ad esempio, dal saggio di Michelangelo Bovero (egli stesso un filosofo politico molto sensibile alla – e molto curioso della – scienza giuridica) su Antigone, così come da non pochi saggi di giuristi immersi in un confronto con la filosofia o con l’economia (cito soltanto il primo e l’ultimo della rubrica saggi, cioè quello di Antonio Baldassarre e quello di Ugo Rescigno).
La rivista, a me sembra, era ed è una scommessa. Il professor Morbidelli giustamente ricorda che le riviste giuridiche navigano in cattive acque, ma – allora – per cercare di continuare a navigare e per navigare bene occorre migliorare la barca; occorre elevare la qualità, alzare il livello della discussione, seminare oggi qualcosa che sperabilmente fruttificherà e si potrà raccogliere domani. Lo sguardo ansioso, ma relativamente ottimista, sul futuro è indispensabile. Speriamo, allora, nel futuro. E intanto rivolgiamo a Lo Stato e agli amici che lo animano auguri affettuosi per questi primi 10 anni. E che ce ne siano molti altri da registrare e celebrare.
«Je me fais de l’université une idée plus médiévale». Con queste parole Michel Villey prendeva posizione sulle riforme universitarie francesi degli anni Settanta e Ottanta e la prendeva quando aveva ancora un senso farlo. Oggi ne ha meno, perché non solo non esiste più quell’università medievale, ma non esiste più (salvo qualche distinguo di cui dirò) nemmeno la sua forma - diciamo così - humboldtiana, la quale a ben vedere costituiva la proiezione e l’adattamento illuministico di quell’antico modello. Che le cose stiano così, nondimeno, non vuol dire ch’esse tali debbano restare. Non v’è - infatti - alcun vincolo promanante da chissà quali superiori fonti che obblighi a conservar le cose in questo stato. Non c’era in occasione della triste vicenda del 3+2, quando ci fu fatto credere all’esistenza di un vincolo europeo (mentre c’erano i soli “princìpi di Bologna”, stipulati in una riunione che non era nemmeno ai più alti livelli politici) e non c’è adesso.
Questo vuol dire che se non si vuole che si perpetui la desolante condizione attuale occorre sforzarsi di contrastarla e occorre farlo anche promovendo politica culturale, nella consapevolezza che i problemi sono risolvibili unicamente nel tempo medio, se non addirittura lungo. Ebbene: Lo Stato è un episodio importante di questa possibile politica culturale e lo è oggettivamente, non perché oggi celebriamo questa rivista di fronte a chi l’ha fondata ed è nostro amico.
A pagina 30 dell’Editoriale che apre l’ultimo numero, che ovviamente si deve ad Aljs Vignudelli, si danno delle indicazioni di metodo che trovo convincenti: «Lungi dall’esprimere rassegnazione, anche alla luce della situazione descritta, la stessa decisione di fondare questa rivista è da intendere come sintomo di uno sguardo fiducioso verso il futuro, e pronto a cogliere il buono pure nel presente». Ora, per cogliere il buono pure nel presente ce ne vuole; ci vuole molta buona volontà e molta fantasia, tuttavia è meglio sforzarsi di provarci anziché limitarsi a fare infruttuoso esercizio di nostalgia, così mobilitando le straordinarie risorse che anche in questo fosco presente continuano a essere disponibili. Pensiamo, a tacer d’altro, a quanto ci offre la rete, all’incredibile messe di fonti e di dati online che da giovani potevamo solo sognare di possedere e che ora sono opportunità straordinarie tali da autorizzare a gettare uno sguardo - pur cautamente - fiducioso nel futuro.
Occorrono però iniziative capaci di aprire un varco, di creare contraddizioni nell’attuale condizione. Occorrono appunto iniziative come questa, che Aljs Vignudelli ha condotto e conduce con l’insostituibile aiuto dei suoi validissimi allievi e collaboratori.
Ma torniamo all’Editoriale che ho appena ricordato e assumiamolo a punto di riferimento, perché si tratta di un contributo che – potremmo dire prendendo all’imprestito una nota concettuologia costituzionalistica – è allo stesso tempo di bilancio e di programma. Esso fa il punto su dieci anni di storia de Lo Stato e, se ha certo ragione Beppe Morbidelli a dirci che dieci anni non sono poi chissà quanti nella vita di una rivista, resta anche vero che, con i ritmi accelerati del tempo di oggi, si tratta pur sempre di un significativo lasso di tempo.
L’Editoriale ha una singolare struttura. Nelle prime pagine ci si immerge nelle caliginose atmosfere della Bassa padana: sentiamo profumi di gnocco fritto e di culatello di Zibello; ci troviamo bambini con i calzoni corti sui banchi di legno, su quei banchi pieni di graffiti a punta di temperino - nemici della comodità e forse amici degli ortopedici - che alcuni di noi hanno sperimentato. Si tratta di una parte che - Aljs lo sa - mi è piaciuta moltissimo: sembra di leggere un racconto di Guareschi; ci si trova improvvisamente in una dimensione quasi onirica. Eppure, quelle pagine non vanno lette solo pel loro pregio letterario o come un amarcord nostalgico. Certo, là dentro c’è un pezzo di vita di Aljs che balza agli occhi con grande vivacità e vivezza, ma c’è anche e soprattutto l’idea che quelle cose andavano scritte per poggiare sulla tavola una sorta di segnaposto della rivista, una qualche marcatura della sua collocazione nella storia, nel fluire della storia e della cultura del Paese.
L’Editoriale propone una complessa filatura di trame di collegamento tra la cultura e l’università che furono e la cultura e l’università che sono oggi, ma fa bene intendere come quella cultura e quell’università scomparse non appartengano a un passato remoto, ma siano - semplicemente - il nostro ieri. Si scrive a pagina XVI: «la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna alla quale ero approdato nel 1967 era [...] un esempio di classicità e compostezza, con un corpo docenti a dir poco stellare». Potrei dire lo stesso della Facoltà giuridica de La Sapienza romana. E potrei dirlo anche non più da studente, ricordando l’anno in cui ritornai da giovane chiamato nel 1996: non chissà quando, ripeto, ma ieri, appunto. Eppure, tanto è cambiato.
C’è a pagina XVII una frase molto bella: «poi è arrivato, furiosamente, il Novecento». È arrivato, in realtà, il Sessantotto e qui si dovrebbe aprire una discussione su ciò che il Sessantotto è stato, anche se lo si dovrebbe fare rifuggendo dallo stucchevole ideologismo che tuttora inquina il confronto. Oggi posso solo limitarmi a mettere in luce il punto – che a me sembra essenziale - della rottura del principio di autorità ch’esso portò con sé, una rottura che positivamente travolgeva l’autoritarismo gerarchico, ma negativamente metteva in discussione anche la stessa autorevolezza, compresa l’autorevolezza riconosciuta alle conoscenze. In ogni caso, il Sessantotto non spiega tutto, non spiega affatto, interamente, la nostra condizione attuale, perché molte altre cose andrebbero tenute presenti.
Mi ha divertito il fatto che a pagina XXII si citi Idiocracy, un filmino - forse un B movie - che anch’io ebbi a ricordare ai miei studenti e che può vedersi su una delle molte piattaforme disponibili in rete. Vi si racconta la storia di un uomo qualunque, di intelligenza media o forse medio-bassa, il quale, per una serie di circostanze fortuite, si ritrova crioconservato per moltissimi anni e al risveglio scopre di essere considerato un genio assoluto: è accaduto, infatti, che il mondo, nel frattempo, s’è popolato di perfetti imbecilli. Il film, divertente pur nella sua semplicità, mette in luce i gravi rischi dei tempi nostri, che potrebbero avere gravi ripercussioni sul futuro. È infatti enormemente aumentato il rischio del cultural divide, perché le nuove tecnologie non offrono solo le grandi opportunità di apprendimento cui accennavo, ma anche numerose occasioni di rimbambimento: occasioni di approfondimento, di acculturazione diversa e ramificata, assai più complessa di quella che noi potemmo esperire negli anni della nostra formazione; ma anche occasioni di abbrutimento, di fruizione passiva di tutto quanto passa nei meandri della rete. Si tratta di una partita aperta, anche se si deve essere consapevoli del fatto che le prospettive peggiori hanno a disposizione delle autostrade, mentre le migliori hanno di fronte soltanto dei sentieri, magari dei sentieri interrotti, degli Holzwege.
È sull’incerto crinale tra l’abisso e la resurrezione che – a me sembra – si muove questa iniziativa editoriale. E vi si muove sulla base di una premessa, accennata a pagina XXIII e poi meglio esplicitata alle pagine XXVII e XXVIII, che in realtà è una presa di posizione, una dichiarazione di appartenenza, una rivendicazione di scuola: «l’idea elementare che si nutriva allora è che il diritto di cui solo valeva la pena di occuparsi fosse quello positivo e che quest’ultimo, perlomeno nei nostri ordinamenti continentali di civil law, fosse ovviamente quello posto ed esternato per iscritto dal legislatore costituzionale e ordinario e che il compito primo della scienza giuridica fosse, in qualità di metalinguaggio, di ricostruire avalutativamente caratteristiche e contenuti del linguaggio oggetto». Tutto questo, si aggiunge, ha lasciato il posto ad altri indirizzi scientifici, ad altre metodologie, e non ci sorprende che ciò si aggiunga con toni critici, perché quale fosse la posizione scientifica di Aljs Vignudelli era noto. Non ci sorprende, appunto, leggere alcuni passi in cui si mette in luce cosa non va. E cosa non va è soprattutto questo: «la vasta gamma di soluzioni caso per caso, le ormai frequenti operazioni di supplenza degli organi giusdicenti, una classe politica distratta, sorda o anche soltanto ipocrita nel non decidere».
Abbiamo, da una parte, un difetto di consapevolezza dei limiti della giurisdizione e dall’altra un difetto di volontà di adempiere ai compiti che sono propri della legislazione. Su tutto questo grava, poi, l’imbarbarimento del dibattito pubblico (si pensi, paradigmaticamente, alla recentissima discussione su un provvedimento giurisdizionale in materia di immigrazione, oggetto di critiche a dir poco sopra le righe). Rincara la dose Aljs parlando di una «infinita serie di sofismi e paralogismi di cui abbonda l’odierna letteratura giuridica, critiche a formule come dialogo tra le Corti, disordine delle fonti» e a pagina XVIII rivela che «è stato proprio anche per reagire al senso di disorientamento determinato da un simile scenario, che nel 2013 abbiamo deciso di dar vita al progetto di cui celebriamo qui il decennale». Un progetto che, si badi, non ha una sua specifica connotazione ideologica, ma vuol fare politica culturale a prescindere da qualunque obiettivo ideologicamente caratterizzato. Che sia così l’attestano dieci anni di rivista; lo dichiarano le affermazioni esplicite di pagina XIX («Lo Stato può forse rientrare nella categoria di quelle che [...] Giannini definiva riviste di dibattito, nel senso che non intende affermare una determinata linea redazionale, ma fa proprio un atteggiamento di apertura nei confronti dei diversi orientamenti»); lo dimostrano gli stessi importanti contributi, ospitati proprio sull’ultimo numero della rivista, che seguono una metodologia giuridica e scientifica lontana le mille miglia da quella prediletta da Aljs e anche dalla sua scuola.
Alla luce di queste considerazioni chiuderei su un interrogativo: cosa deve fare il giurista, il giurista che ha da misurarsi con problemi di questa portata? Cosa deve fare il giurista che intende contrapporsi allo smarrimento della scienza giuridica? È ovviamente ben difficile da dire, ma a mio avviso deve anzitutto avere un contatto con le altre scienze dello spirito e in generale con tutte le altre scienze. La scienza giuridica ha qualche difficoltà a farsi ospitare nel classico dualismo windelbandiano che distingueva tra scienze nomotetiche e scienze idiografiche, poiché esibisce tratti propri dell’una e dell’altra famiglia, ma proprio per questo è una disciplina (chiamiamola così, se “scienza” ci sembra troppo impegnativo), che è caratterizzata da una naturale apertura verso gli altri tipi di conoscenza. Chi rimprovera al giurista d’essere chiuso nel suo particulare forse non si rende conto ch’egli – invece – proprio a causa di questa indeterminatezza del suo ubi consistam è addirittura costretto a guardare al di là degli apparenti steccati specialistici dei suoi studi. Apertura, poi, è anche interdisciplinarità, frequentazione di biblioteche che non siano esclusivamente giuridiche, presenza nella propria biblioteca di libri che non siano soltanto di diritto; dialogo fitto con gli altri specialismi.
L’ultimo numero de Lo Stato, da questo punto di vista, è un paradigma e basta scorrere l’indice per intenderlo: la fittissima interlocuzione con le altre scienze dello spirito è attestata, ad esempio, dal saggio di Michelangelo Bovero (egli stesso un filosofo politico molto sensibile alla – e molto curioso della – scienza giuridica) su Antigone, così come da non pochi saggi di giuristi immersi in un confronto con la filosofia o con l’economia (cito soltanto il primo e l’ultimo della rubrica saggi, cioè quello di Antonio Baldassarre e quello di Ugo Rescigno).
La rivista, a me sembra, era ed è una scommessa. Il professor Morbidelli giustamente ricorda che le riviste giuridiche navigano in cattive acque, ma – allora – per cercare di continuare a navigare e per navigare bene occorre migliorare la barca; occorre elevare la qualità, alzare il livello della discussione, seminare oggi qualcosa che sperabilmente fruttificherà e si potrà raccogliere domani. Lo sguardo ansioso, ma relativamente ottimista, sul futuro è indispensabile. Speriamo, allora, nel futuro. E intanto rivolgiamo a Lo Stato e agli amici che lo animano auguri affettuosi per questi primi 10 anni. E che ce ne siano molti altri da registrare e celebrare.
Massimo Luciani
Università degli Studi di Roma - La Sapienza
Università degli Studi di Roma - La Sapienza